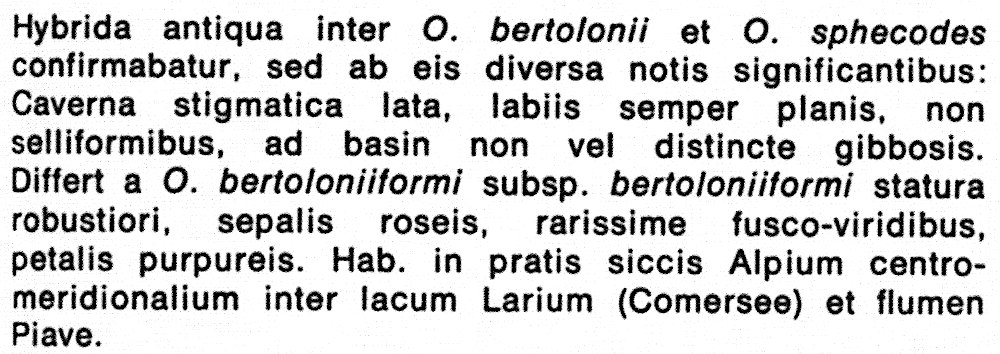Ophrys benacensis insieme alla provenzale Ophrys saratoi, sconfinante nel Ponente ligure, sono importanti taxa di origine ibridogena nella ser. Bertoloniorum. L’attività ibridogena (e probabilmente introgressiva) che ha dato origine a questi paleoibridi è avvenuta tra Ophrys bertolonii e Ophrys sphegodes s.l. Sia in Liguria che in Provenza vi sono aree dove le due specie sono in piena sintopia. L’altra entità provenzale Ophrys aurelia P. Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers 1989, secondo Delforge (2016: 496) presente anche in Liguria (con una segnalazione anche sul versante cuneese delle Alpi liguri in Morelli & Lombardo 2022: 269), almeno in Italia non sembra distinguibile da Ophrys benacensis.
Nell'Appennino settentrionale poi è impossibile definire il limite dove finisce O. benacensis e inizia O. bertolonii: le poche segnalazioni riguardano esemplari con caratteri intermedi tra le 2 entità. La sua presenza appare in regresso nell’area dove essa è maggiormente diffusa, quella insubrica (Perazza & Lorenz 2013: 306), sia verso ovest, dove non supera il ramo lariano di Lecco, sia verso est, poco oltre il confine tra Veneto e Friuli; tuttavia più recentemente è stata segnalata molto più a est, nel Carso triestino (M. Cartagine in Martini 2019: 36-37).
Bibliografia citata:
> DELFORGE P., 2016: Orchidées d'Europe... 4° éd., Delachaux et Niestlé, Paris (F).
> MARTINI F., 2019: Aggiornamenti alla flora del Friuli Venezia Giulia (Italia nord-orientale). n.s. IV (85-117). – Gortania 41: 31-46.
> MORELLI F. & LOMBARDO R., 2022: Le orchidee spontanee della Provincia Granda. 2° ed., Edizioni La Cevitou, Ecomuseo, Villa San Pietro (CN).
> PERAZZA G. & LORENZ R., 2013: Le orchidee dell'Italia nordorientale. Ed. Osiride, Rovereto (TN).